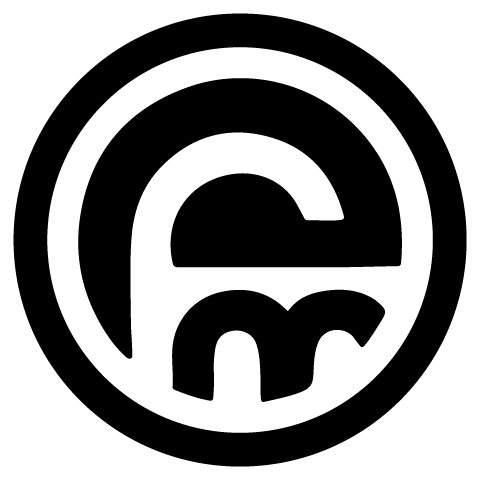Quando mi sono iscritta alla facoltà di Ingegneria, eravamo una sparuta decina di donne in un’aula di circa mille matricole. Ricordo nitidamente il primo giorno di lezione: cercavo qualcuno in cui potermi riconoscere, un volto, uno sguardo simile al mio. Ne incrociai pochi, un po’ spaesati. Sembrava chiaro fin da subito che non sarebbe stato un cammino facile: non solo per le difficoltà accademiche, comuni a tutti, ma perché noi donne dovevamo prima di tutto legittimare la nostra presenza in quel contesto. Dovevamo guadagnarci il diritto di esserci.
Nel tempo ho imparato che quella sensazione non era solo mia. E tuttora, tantissime donne che lavorano in ambito STEM condividono lo stesso fardello: il senso costante di “non appartenenza”; la fatica di dover sempre dimostrare di sapere, di valere; il sentirsi ospiti in un luogo che dovrebbero invece poter chiamare “casa” e la sensazione opprimente che basti un piccolo passo falso per confermare pregiudizi pronti a essere tirati fuori.
Mi torna spesso in mente un episodio accaduto a una mia collega ai tempi dell’università.
Portava le unghie lunghe, ben curate e un giorno, durante una lezione, il professore le disse che con quelle unghie non sarebbe mai riuscita a scrivere codice decentemente.
Aggiunse che, per questo motivo, l’avrebbe bocciata.
Non una battuta, non un invito al miglioramento, ma una sentenza basata sull’aspetto.
Non erano le sue competenze a essere valutate, ma un dettaglio estetico completamente irrilevante.
Un pregiudizio, sottile ma violento. E purtroppo non isolato.
Perché i pregiudizi non sono sempre gridati, spesso sono sussurrati.
Una parola di troppo, un’occhiata dubbiosa, un’esclusione non dichiarata. Ma fanno male uguale.
E alla lunga lasciano il segno, condizionano le scelte, smorzano gli entusiasmi.
E poi, anche quando si supera il primo scoglio e si entra nel mondo tech, molte di noi si trovano ad affrontare un ostacolo meno visibile, ma altrettanto insidioso: la sindrome dell’impostore.
È una presenza subdola, una voce interna che sminuisce ogni conquista, che insinua dubbi anche di fronte ai traguardi più solidi.
Non nasce dal nulla: si nutre dell’ambiente che ci circonda. Di team dove spesso sei l’unica donna. Di riunioni in cui ti senti costretta a spiegare più del dovuto. Di errori che sembrano pesare il doppio.
Anch'io, con una laurea in ingegneria, varie qualifiche e certificazioni professionali... ho avuto momenti in cui ho pensato: forse non sono davvero abbastanza per stare qui.
Poi, per fortuna, mi sono sempre ricordata perché ci sono: perché valgo, per costruire, per creare e per aprire strade a chi verrà dopo. E provare nel mio piccolo, fosse solo per una, a essere un modello.
Perché so che crescere senza modelli è come cercare una strada senza sapere se porta davvero da qualche parte. Se guardiamo ai libri, ai film, ai curricula degli speaker nei convegni, troviamo quasi sempre figure maschili. Eppure le donne ci sono sempre state, anche nella storia dell'informatica.
Ada Lovelace scrisse il primo algoritmo. Grace Hopper inventò il primo compilatore.
E, più di recente, Marissa Mayer ha contribuito in modo decisivo allo sviluppo di Gmail e Google Maps. Susan Wojcicki ha guidato la trasformazione di YouTube.
Ma queste storie restano troppo spesso ai margini: raccontate tardi, o mai.
Allora la domanda che dobbiamo farci è: cosa possiamo fare per cambiare rotta? Per incoraggiare le ragazze a scegliere, e soprattutto a restare, nei percorsi STEM?
Il primo passo è l’educazione. Dobbiamo parlare di scienza, matematica, informatica e tecnologia con le bambine sin dalle scuole primarie, presentandole come discipline affascinanti, stimolanti e aperte a tutti. Dobbiamo proporre esperienze che le mettano in condizione di sperimentare, sbagliare, riprovare, senza paura di essere giudicate “fuori posto”.
Il secondo passo è creare ambienti di studio e di lavoro più accoglienti.
Serve formazione per i docenti, affinché sappiano riconoscere e superare stereotipi radicati;
serve una selezione più consapevole da parte di chi assume; mentoring per accompagnare chi entra nel mondo del lavoro; esempi concreti di donne in ruoli di leadership.
Ma soprattutto, serve una cultura aziendale che non chieda alle donne di adattarsi a standard maschili, ma che sappia valorizzare stili di leadership diversi, capacità relazionali e visioni nuove.
Una cultura che non consideri la diversità un ostacolo da tollerare, ma un valore da coltivare.
Infine, servono storie. Tante. Serve raccontare, far vedere, normalizzare. Se una ragazza vede una donna che fa la scienziata, l’ingegnera, la programmatrice, allora potrà iniziare a immaginare anche se stessa in quei panni. E potrà farlo senza vergogna, senza doversi giustificare.
Non sarà un cambiamento rapido, ma può cominciare da piccoli gesti.
Forse, anche da un blog come questo. Anche da una voce come la mia.
Serve che chi è già dentro, come me, non si stanchi di parlarne. Perché ogni storia, ogni esperienza condivisa, può essere una piccola luce accesa sul cammino di chi sta iniziando.
E se mia nipote, un giorno, deciderà di metter piede in un’aula di ingegneria, spero che non debba cercare volti simili al suo con paura, ma con orgoglio. E sappia fin da subito che quel posto è anche suo.
Perché la tecnologia ha bisogno di noi donne: del nostro sguardo attento, della nostra sensibilità concreta, del nostro intuito, della nostra visione capace di includere, prevedere e creare.
Deve sentirlo con fierezza che anche in questi contesti, possiamo esserci, restare e soprattutto contare.